Dario Bonanomi
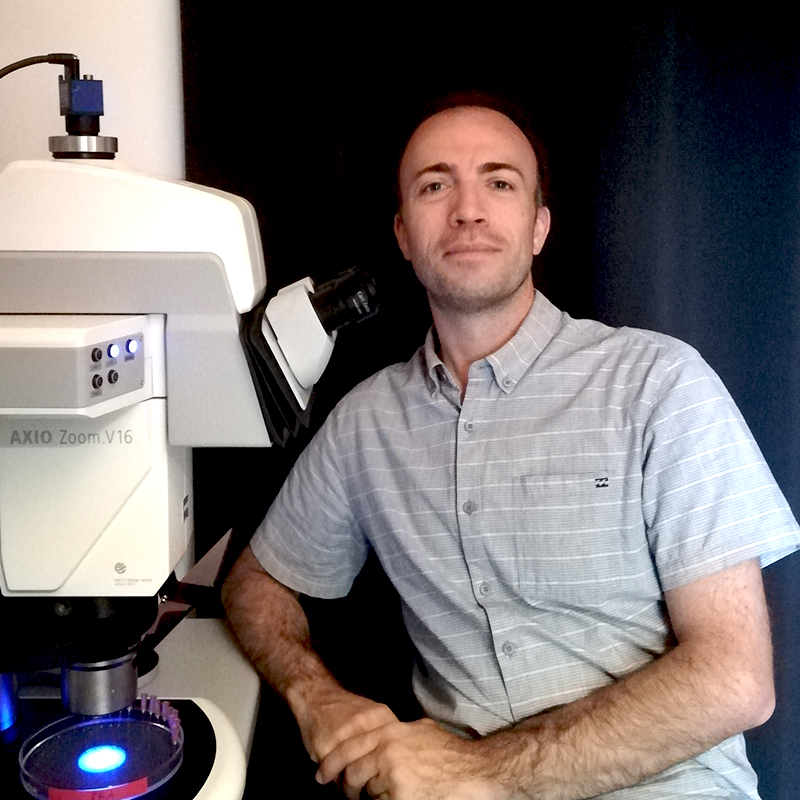
Sono nato a Bergamo, ho 47 anni, sono sposato e papà di due figli di 9 e 7 anni. Sono diventato ricercatore perché affascinato dall’organizzazione e funzionamento del cervello e poi dalla biologia cellulare in generale e lo sviluppo embrionale. Fare ricerca è sembrata la continuazione naturale della passione per lo studio della biologia. Una volta provata l’emozione della scoperta, grande o piccola che sia, non è stato più possibile tornare indietro.
Il mio augurio è che venga tenuto vivo l’interesse per la ricerca di base senza la quale è improbabile un vero progresso nella medicina, e la speranza di poter contribuire con i nostri studi a questa avventura della scoperta scientifica.
Dopo un dottorato a Milano sono andato in USA per un’esperienza di postdoc, al Salk Institute di San Diego. Pensavo di restare solo qualche anno ma ne sono trascorsi quasi dieci. Lì ho cominciato a lavorare sullo sviluppo dei motoneuroni spinali, in particolare sulle molecole che guidano le loro proiezioni durante la formazione delle connessioni neuromuscolari.
Tra le tante figure eccezionali, in vari ambiti e discipline, da cui trarre ispirazione penso al grande studioso della struttura delle proteine e Nobel per la chimica Max Perutz, di cui ricordo una favolosa lezione ormai in tarda età, in cui traspariva l’umiltà ancora prima del genio. Su internet si può trovare una sua foto del 1938 in cui studia la formazione dei cristalli di ghiaccio in una grotta-laboratorio nel cuore delle Alpi, con i piedi in sacchi riempiti di paglia per riscaldarsi. Un esempio di perseveranza.
Da studente ho avuto anche la fortuna di visitare il laboratorio del neurobiologo Paul Greengard, Nobel per la medicina per lo studio della trasmissione sinaptica. Nonostante avesse superato gli 80 anni con una carriera straordinaria alle spalle, mi ha raccontato con brio delle ultime scoperte del suo laboratorio, certo che quell’anno sarebbe stato uno dei migliori di sempre. Questo per sottolineare della passione e curiosità che tengono giovane lo spirito.
Sono arrivato allo studio della SLA attraverso il mio lavoro sulla biologia e sviluppo dei motoneuroni spinali, le cellule che vengono colpite dalla malattia. Credo che il segreto per capire questa patologia ancora così enigmatica stia nella comprensione profonda dei meccanismi che regolano la fisiologia dei motoneuroni e le loro interazioni con le cellule circostanti.
Il nostro progetto ha lo scopo ambizioso di identificare nuovi marcatori della SLA e di comprendere i processi alla base dell’insorgenza e propagazione della malattia. Andremo alla ricerca di molecole presenti nel sangue o nel liquido cerebrospinale che possano accelerare la diagnosi della SLA e indirizzare la scelta dei trattamenti. Grazie alla collaborazione tra biologi e clinici ci aspettiamo di chiarire il ruolo dei nervi periferici nella patogenesi della SLA, e sulla base di questa conoscenza confidiamo di poter scoprire nuovi bersagli terapeutici.
Tra le passioni che mi hanno aiutato anche nel lavoro, c’è quella per l’alpinismo che mi ha forse dato una struttura organizzativa e caratteriale utile nel lavoro di laboratorio. Seguendo questo interesse, nel 2019 abbiamo dato a un gene che guida le proiezioni dei motoneuroni il nome del grande scalatore lecchese (Riccardo) “Cassin. (data pubblicazione 26/02/2024)